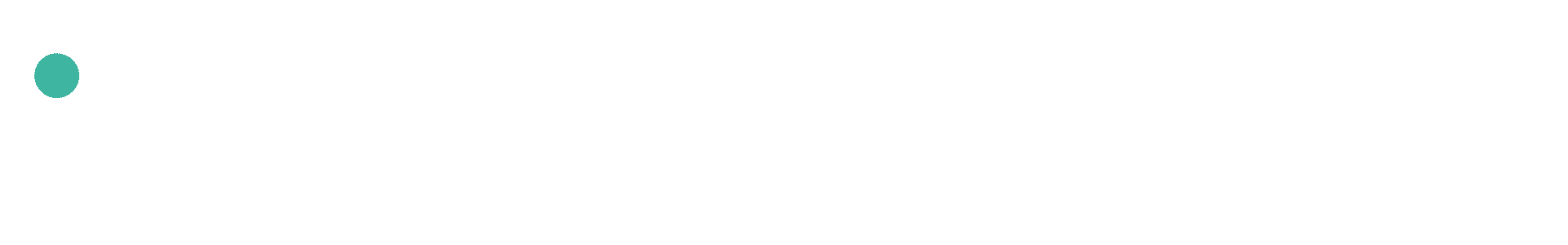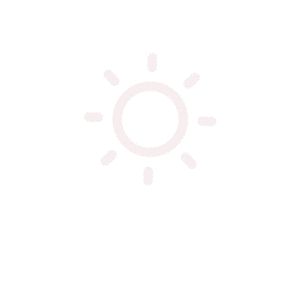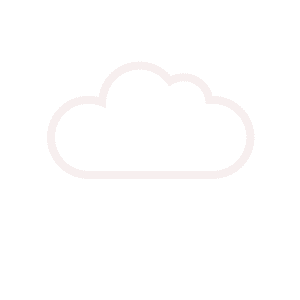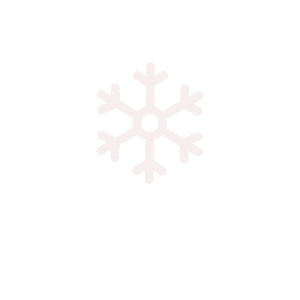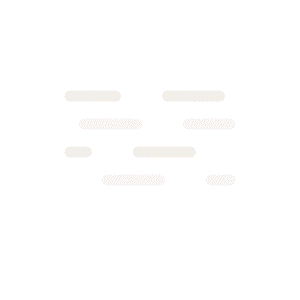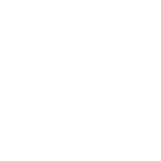Scrittori di Classe – Storie di mare è un progetto rivolto alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e private paritarie che ha visto la partecipazione di migliaia di scuole italiane. L’iniziativa si è posta l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle scienze marine e dei concetti di sostenibilità legati al mare, promuovendo tra le giovani generazioni l’accesso alle materie STEM.
Grazie alla collaborazione fra Conad e l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR), gli alunni hanno potuto approfondire la conoscenza del mare e raccontare le loro idee per un futuro e un mondo più sostenibili, in cui i nostri oceani possano davvero essere delle oasi di benessere e di prosperità!
Le 12 classi vincitrici, 2 per ogni incipit parteciperanno a una giornata di premiazione organizzata per loro. I loro 12 racconti entreranno a far parte del grande libro Storie di Mare che sarà disponibile in distribuzione gratuita presso tutti i punti vendita Conad a partire da marzo 2023.
Anche i materiali didattici realizzati nell’ambito dell’iniziativa e rivolti ai 2 percorsi scolastici della scuola primaria di primo grado e di secondo grado, insieme ai webinar realizzati per gli insegnanti con il supporto dei ricercatori dell’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono disponibili e accessibili gratuitamente al link:
https://insiemeperlascuola.conad.it/atpc/insiemeperlascuola/j/scrittori-di-classe-materiali-concorso
Giovedì 2 marzo 2023 alle ore 11:00, presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR di Venezia, si terrà il momento conclusivo di questa iniziativa. L’evento, organizzato in modalità ibrida, vedrà la partecipazione dei Relatori e di una delle classi vincitrici – Scuola Elementare Montagnana (PD) – premiata in presenza; oltre ai Rappresentanti di Conad e dellla stampa. Le altre scuole premiate saranno collegate da remoto.
Per motivi logistici la partecipazione è possibile solo online con le seguenti modalità:
Riunione di Microsoft Teams
Partecipa da computer, app per dispositivi mobili o dispositivo della stanza
Fai clic qui per partecipare alla riunione
ID riunione: 375 002 709 320
Passcode: 9wxsjt
Scarica Teams | Partecipa sul Web
In alternativa, partecipa tramite chiamata (solo audio)
+39 02 0062 4808,,998555519# Italy, Milano
ID conferenza telefonica: 998 555 519#
Download: