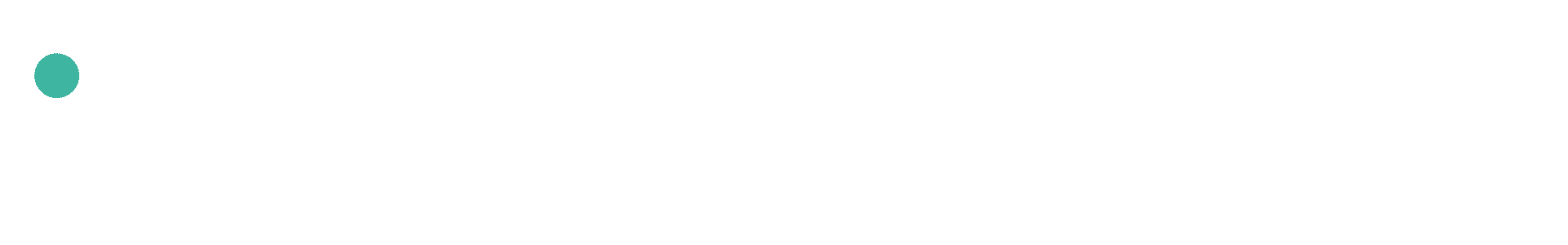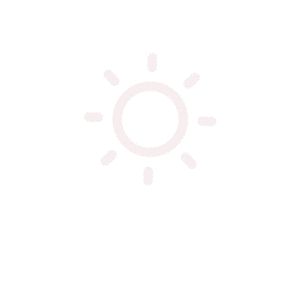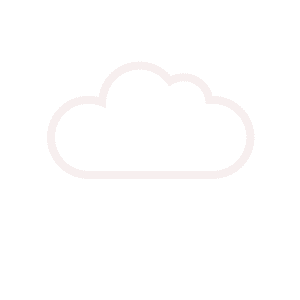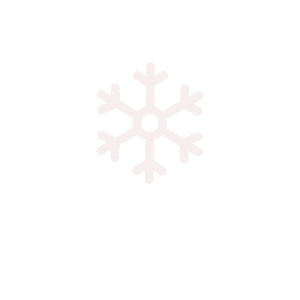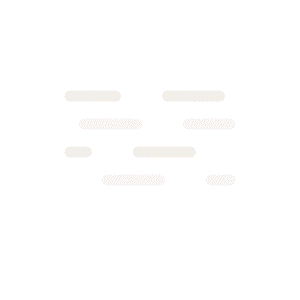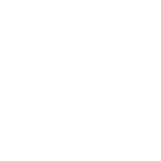Noi tutti sappiamo quanto la Laguna veneziana sia un esempio di ricchezza e unicità. Un vero e proprio ecosistema che ospita una vasta biodiversità, modello perfetto della coesistenza comunitaria tra specie. Questo ambiente, dalla connotata morfologia, è teatro di risultati ed effetti in costante mutamento poiché fluida è la natura della sua eterna protagonista: l’acqua.
Venezia è l’incredibile testimonianza della “volontà”: non nasce spontaneamente, anzi esiste grazie alla continua negoziazione tra l’uomo e la natura. Dai primi insediamenti, alla potenza della Serenissima, fino alla città che oggi conosciamo, tutto si regge su equilibri cristallini che sono da sempre motivo d’ispirazione creativa e oggetto di indagine scientifica.
In questo appuntamento ci concentreremo infatti su quelle relazioni tramite il lavoro dell’artista Roberto Ghezzi e le ricerche del Dott. Gian Marco Scarpa.
Ghezzi da anni porta avanti il progetto Naturografie©: consegna al paesaggio e al tempo i supporti da lui preparati in precedenza, in maniera che si “impressionino” della vita e della presenza di un determinato contesto ambientale. In attesa della sua futura produzione a Venezia in concomitanza con la Biennale 2022, che vedrà la collaborazione tra Giudecca Art District (GAD) e la galleria EContemporary che lo rappresenta, l’autore ci introdurrà alla sua opera e al percorso da intraprendere nelle tipicità del nostro territorio.
Gian Marco Scarpa è assegnista di ricerca al CNR-Istituto Scienze Marine di Venezia dove si occupa di indagini ambientali idrodinamiche e geomorfologiche con particolare attenzione agli impatti sull’ecosistema costiero causati dall’agente umano.
Qui disponibile il link dell’evento organizzato da GAD:
https://www.facebook.com/events/963816651114620?active_tab=about